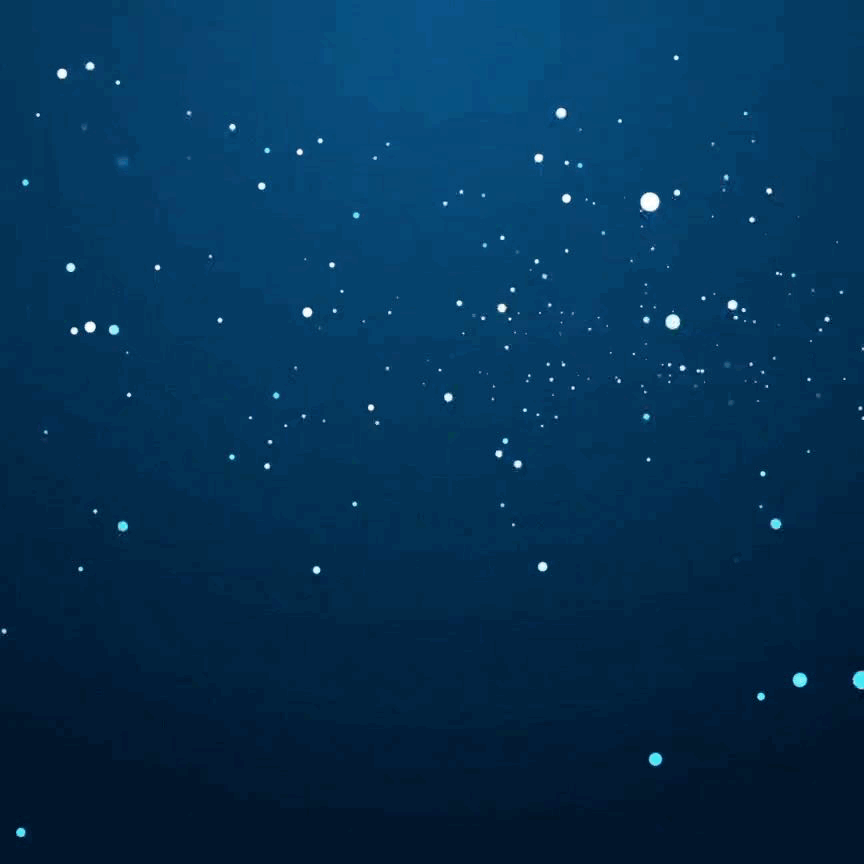L’Ordinanza n.67 del 31 marzo 2025, con la quale il ministro Valditara ha disciplinato – in ossequio a quanto stabilito dalla Legge 1 ottobre 2024 n.150, recante modifiche alla valutazione del comportamento di alunni e studenti – l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico 2024/2025, ha il pregio di mettere con coerenza al centro dei requisiti di ammissione la valutazione del comportamento degli studenti. Già durante l’iter di approvazione della citata legge – attraverso la presa di posizione del Presidente Fratta – DIRIGENTISCUOLA aveva salutato con grande favore l’intervento sul tema della valutazione del comportamento da parte del ministro, condividendone appieno le finalità, pur non mancando di denunciare – al contempo – l’urgenza di un orientamento ancora più incisivo, che privilegiasse un approccio culturale alla prevenzione, all’educazione e alla formazione dei discenti, perché “si comporta e agisce come si pensa”.
Già vent’anni fa Umberto Galimberti proponeva, per gli alunni che infrangevano le regole, ore aggiuntive di educazione civica da svolgere con docenti retribuiti – per quelle ore – a carico delle famiglie. Ore da dedicare ad approfondire non manuali teorici, bensì testi che parlassero di violenza fisica, psicologica e del linguaggio. E solo pochi giorni fa lo stesso Galimberti, intervenendo sulla responsabilità genitoriale, ha sostenuto che “i padri non parlano con i bambini perché si annoiano. Le madri parlano, ma a livello di raccomandazioni pratiche, tipo il prestare attenzione per strada oppure l’asciugare i capelli per bene. Mai domande che si elevino al livello psicologico di confronto, tipo <<sei felice?>>. Bisogna parlare tanto con i figli e – altrettanto – ascoltarli. Invece i genitori, in cambio delle parole mancate, riempiono i figli di regali. Regali al compleanno, regali a Natale, regali a Pasqua, regali alla fine dell’anno, regali se sono promossi. Quei regali sono dei veri e propri delitti, perché uccidono il desiderio. Il desiderio è mancanza, ma se le cose le dai ai figli prima ancora che le desiderino, l’attivazione psichica per raggiungere l’oggetto del desiderio non avviene, e il figlio non si attiva più. E i genitori poi arrivano a dire: mio figlio non desidera niente. Ma i genitori d’oggi non comprendono che la mancanza di desiderio è il conto da pagare per tutti i regali fatti.”
Da diversi anni anche Paolo Crepet – che sovente interviene in tema di responsabilità genitoriale – sostiene che “educare è togliere, perché se i bambini hanno tutto, non impareranno mai a desiderare e a conquistare”.
È di tutta evidenza – a parere di DIRIGENTISCUOLA – che l’educazione alla vita, che si apprende anche sui banchi di scuola, è indispensabile passi attraverso una sofferenza necessaria, della cui inevitabilità ogni genitore dovrebbe essere consapevole, poiché eccessive tutele consegnerebbero alla società figli – e cittadini – passivi e privi di slanci, quando non addirittura protagonisti di comportamenti devianti. Da dove arriva la facilità con la quale si smerciano sostanze stupefacenti, si rubano auto in pieno giorno e a volto scoperto, si svaligiano appartamenti anche videosorvegliati? Non nasce forse dalla consapevolezza che il prezzo eventualmente da pagare (spesso esiguo o inesistente) valga la pena di correre il rischio? La sempre più blanda punibilità dei comportamenti sbagliati – che si trasforma in sostanziale impunibilità – nasce proprio da quel luogo formativo primario che è la famiglia, la quale sovente sperimenta un vissuto di esenzione dalle responsabilità che contagia la società e la scuola.
Massimo Recalcati, senza mezzi termini, ha recentemente parlato del “dato drammatico e scoraggiante rappresentato dalla rottura del patto educativo che vincolava genitori e insegnanti nel difficile compito di educare, con genitori che fanno i sindacalisti dei figli e un corpo docente sempre più isolato, maltrattato economicamente e dileggiato socialmente” e poi ancora di “un’altra cifra perversa del nostro tempo: quella dell’autoformazione, del delirio di formarsi da soli. La formazione implica sempre l’incontro con l’altro, l’incontro con un maestro. Abbiamo bisogno di maestri. E benedetti i maestri, visto che siamo nel tempo dell’estinzione dei maestri!”
A parere di DIRIGENTISCUOLA emerge in modo incontrovertibile, dalle parole degli intellettuali citati, la necessità di un intervento normativo sistematico che imponga per legge:
- di costituire un sistema di sanzioni da comminare durante l’anno scolastico che induca l’alunno o lo studente a costruire la consapevolezza dell’esistenza del senso del limite;
- alla famiglia una rinnovata responsabilità genitoriale ed educativa, con responsabilità personale oggettiva – civile e penale – dei genitori in ordine ai comportamenti dei figli;
- in caso di comportamenti scolastici negativi, l’obbligo per gli alunni, gli studenti e i genitori di seguire insieme e a cadenza settimanale percorsi rieducativi alla socialità e al rispetto verso l’altro, che in caso di mancata frequenza configurino elusione dell’obbligo di istruzione con conseguenze penali per i genitori stessi.
“DIRIGENTISCUOLA – conclude il Presidente Fratta – nell’interesse di tutto il sistema scolastico e dei nostri giovani è pronta a collaborare con il ministero per scrivere un nuovo patto scuola-famiglia adatto ai difficili tempi che viviamo. Se vogliamo salvare la scuola italiana – e non solo la scuola – la strada maestra è questa.”